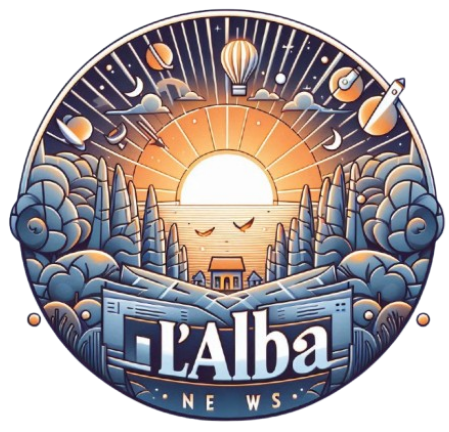La biografia “La speranza non è una strategia” svela il costo umano delle decisioni di Mario Draghi: dubbi, solitudine e responsabilità dal MIT alla BCE.
Cristina La Bella, in Mario Draghi: La speranza non è una strategia, costruisce un profilo che evita l’agiografia: 40 capitoli, ciascuno aperto da una frase di Draghi, per raccontare non solo i successi pubblici ma la solitudine del leader, la fatica di scegliere quando ogni opzione ha un costo. La scelta è quella di parlare di politica non come tifo, ma come etica delle decisioni. Il libro parte dalla formazione (gli anni difficili dopo la morte precoce dei genitori, l’educazione esigente e poi il MIT) e arriva ai vertici europei, mettendo in fila i momenti in cui Draghi ha dovuto tenere la rotta controvento, dal 2012 al 2022.
La solitudine come condizione del comando
Il leitmotiv del libro è che la speranza non basta: serve metodo. Ma il metodo, quando la posta è altissima, isola. L’esempio-simbolo resta l’estate 2012, quando da presidente della BCE Draghi pronunciò il suo celebre “whatever it takes” per salvare l’euro. Quella frase, in tre parole, riaccese la fiducia dei mercati e preparò le misure straordinarie che avrebbero difeso l’integrità dell’Unione monetaria. Dietro il tonfo e la successiva calma, c’è l’idea – molto “draghiana” – che il capo debba assumersi la responsabilità di un impegno pubblico chiaro e poi reggere la pressione che ne deriva.
Dalle stanze dell’euro alle stanze di Palazzo Chigi
Il libro insiste su un’altra solitudine: quella del 2022, quando, da Presidente del Consiglio, Draghi rassegna le dimissioni dopo la fine della maggioranza di unità nazionale. È una scelta che la biografia legge come atto di coerenza rispetto al suo modo di intendere il mandato: senza “patto di fiducia”, non si governa. Le cronache ricordano il passaggio istituzionale (prima dimissioni respinte da Mattarella, poi la fine del governo e l’avvio della fase elettorale), ma ciò che interessa qui è il costo umano di dire “no” alla sopravvivenza politica e “sì” alla responsabilità. È una scena di leadership nuda, senza effetti speciali.
La Bella mostra come Draghi trasformi l’atteggiamento (la speranza) in strategie verificabili: definire obiettivi, ancorare scelte a dati, dichiarare i vincoli e poi rendere conto. È la stessa logica che ritroviamo oggi nel grande rapporto sulla competitività europea preparato per la Commissione: diagnosi severa, proposte operative, invito a cambiare scala e sequenza delle politiche. Non è un “uomo solo al comando” per carattere: è che, quando nessuno vuole pagare il prezzo di una decisione, qualcuno deve farlo.
Scrivere di Draghi così – non come “salvatore”, ma come capo che paga un prezzo personale – serve a capire il dibattito del 2025 su Italia ed Europa: le riforme non vivono di slogan, vivono di scelte impopolari ma necessarie, spiegate bene e misurate nel tempo. In questo senso, la biografia è utile anche a chi non ne condivide le ricette: restituisce il retrobottega delle decisioni, i dubbi e i compromessi, e dunque un’idea più adulta di cittadinanza informata. E ricordare quel 2012 non significa nostalgia: significa chiedersi se oggi, davanti alle ben note contingenze internazionali che rendono il mondo quantomai instabile, esista ancora qualcuno disposto a dire – e sostenere – il proprio “qualunque cosa serva”.