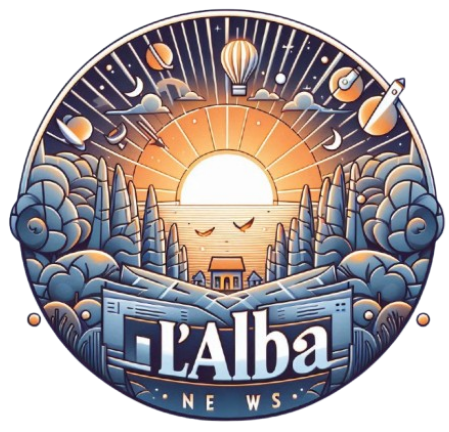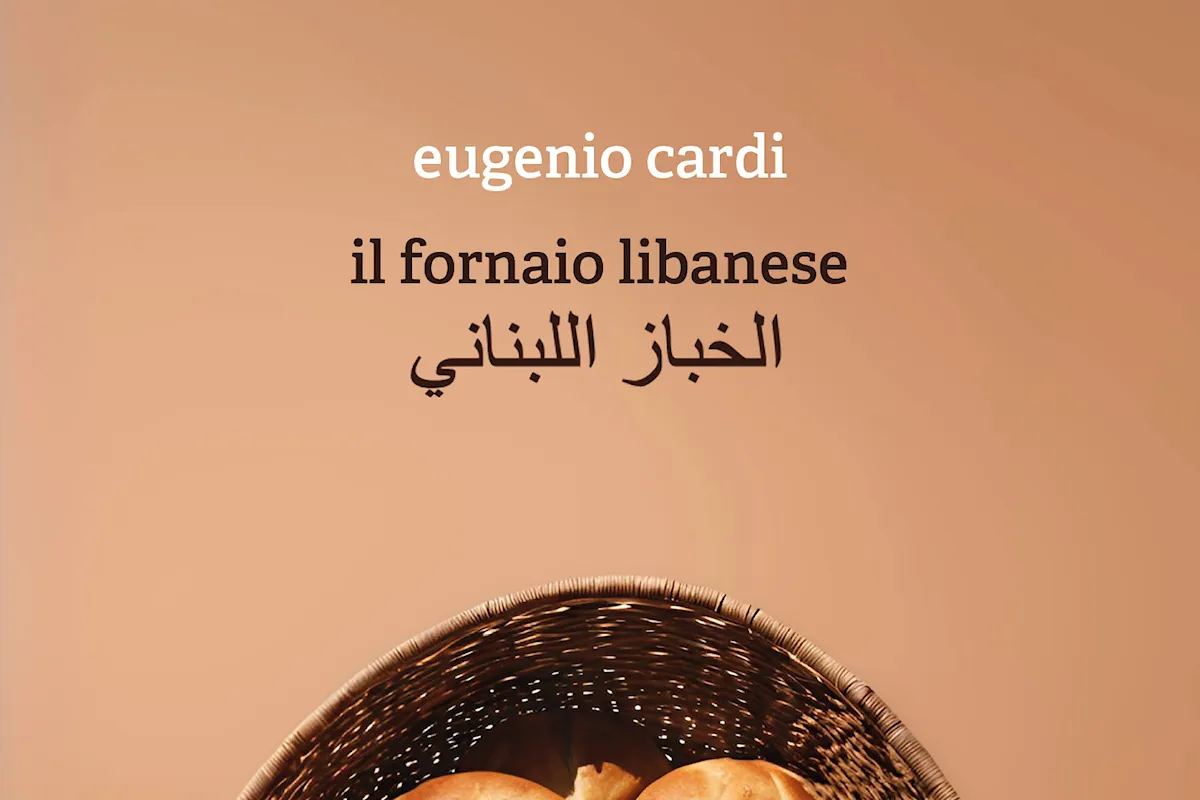Nel romanzo Il fornaio libanese di Eugenio Cardi la guerra in Libano si racconta dal forno di Ibrahim: pane, memoria e resistenza quotidiana.
In mezzo alle cronache di bombe, fronti e trattative internazionali, c’è sempre qualcuno che apre un forno, impasta il pane, prova a tenere in piedi una parvenza di normalità. È da qui che parte Il fornaio libanese di Eugenio Cardi (Santelli Editore), romanzo ambientato a Beirut durante l’invasione israeliana del 1982, che sceglie un punto di vista preciso: quello dei civili che la guerra la subiscono, più che raccontarla.
Il protagonista, Ibrahim, è un ex professore di letteratura che, dopo la morte del padre, prende in mano il forno di famiglia proprio nei giorni in cui i carri armati entrano in città. Quel forno diventa subito molto più di un semplice esercizio commerciale: è rifugio, scuola improvvisata, luogo di una resistenza quotidiana che passa dalla farina e dall’acqua prima ancora che dalle armi. Ogni pagnotta sfornata è un atto di cura, ma anche una dichiarazione politica: “noi siamo ancora qui”.
Accanto a lui si muovono personaggi che tengono insieme memoria personale e memoria collettiva: Najma e Zaynab, sorelle palestinesi, incarnano la resilienza femminile e la vita dei rifugiati, costretti a ricominciare ogni volta da capo; ci sono combattenti, intellettuali, bambini che imparano a leggere tra un bombardamento e l’altro. Il romanzo intreccia così le storie individuali con i grandi snodi storici: dalla Nakba del 1948 ai campi profughi, fino al massacro di Sabra e Shatila, passando per la quotidianità di una Beirut che prova ostinatamente a restare una città viva, non solo uno scenario di guerra.
Cardi costruisce un testo che è insieme romanzo storico, racconto civile e denuncia. Dietro la finzione narrativa c’è una documentazione accurata: la guerra del Libano viene ricostruita attraverso riferimenti geopolitici, culturali e sociali, ma il centro resta sempre lo sguardo “dal basso”, quello di chi non compare nei comunicati ufficiali. Il forno di Ibrahim diventa così un osservatorio privilegiato: da lì passano combattenti e civili, notizie e voci, paura e speranza.
Uno degli aspetti più forti del libro è proprio la scelta del pane come simbolo. Non solo nutrimento, ma rito collettivo, collante di una comunità che si rifiuta di essere ridotta a “danno collaterale”. Il forno è un bersaglio possibile, ma è anche l’ultimo presidio di normalità in un contesto dove tutto sembra spingere verso la disumanizzazione. In questo senso Il fornaio libanese è un romanzo che parla di guerra, ma soprattutto di resistenza civile: della fatica di restare umani quando il mondo intorno sembra lavorare per il contrario.
Il libro è anche un modo per riportare al centro del dibattito una prospettiva spesso marginalizzata nel racconto occidentale dei conflitti in Medio Oriente: quella del popolo palestinese e delle vittime civili, di chi la guerra la vive nei vicoli, nei mercati, nei forni, non nelle stanze del potere. Non a caso la prosa di Cardi mescola momenti quasi lirici a passaggi durissimi, in cui la violenza è restituita senza compiacimenti, ma senza edulcorazioni.
Il fornaio libanese si inserisce così nella tradizione dei romanzi civili che usano la narrativa per tenere aperta una ferita di memoria. Non offre soluzioni semplici, non è un pamphlet, ma una storia corale che chiede al lettore di fermarsi e ascoltare chi, troppo spesso, non ha voce. In un tempo in cui la guerra torna ciclicamente nei titoli dei giornali, la scelta di guardarla dal forno di un quartiere di Beirut – tra bruciature di pane e sirene antiaeree – è già, di per sé, una posizione politica: schierarsi dalla parte di chi prova, nonostante tutto, a sfornare futuro.