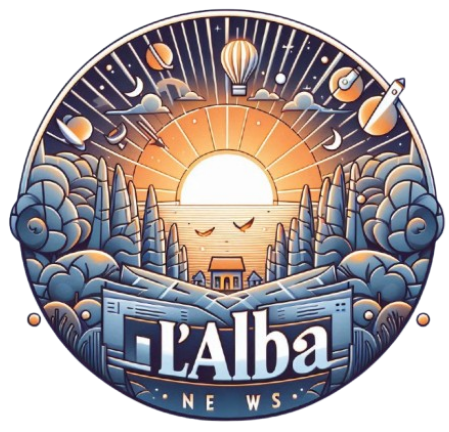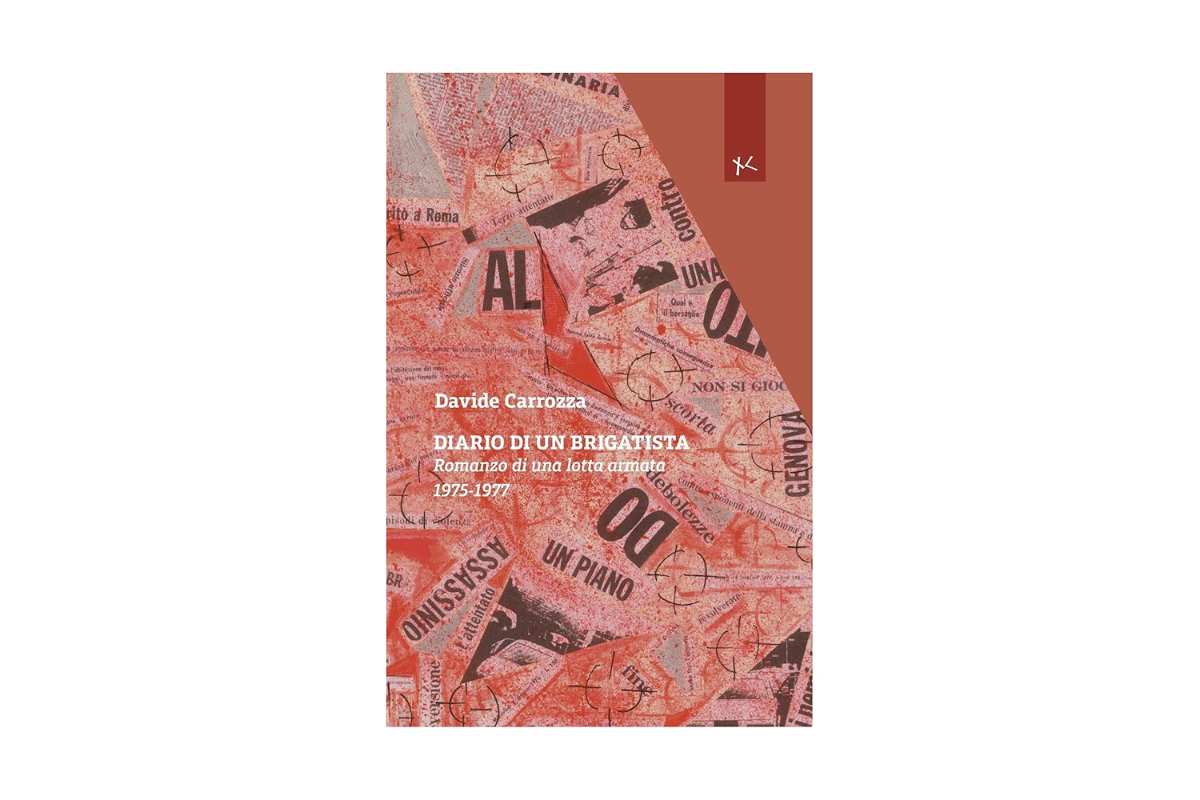Un romanzo che racconta gli anni di piombo attraverso la voce di un ex militante immaginario: alla scoperta di Diario di un brigatista.
Parlare di Brigate Rosse significa, ancora oggi, muoversi su un terreno fragile. Non tanto per la distanza storica — che pure esiste e per altro va crescendo secondo dopo secondo — quanto per il carico emotivo, politico e simbolico che quella stagione continua a esercitare. Gli Anni di Piombo rappresentano un nodo irrisolto della memoria collettiva italiana, difficile da raccontare senza cadere nel giudizio o nella spettacolarizzazione. Diario di un brigatista, romanzo di Davide Carrozza, sceglie invece una via diversa: quella della narrazione soggettiva, del memoriale immaginario, della voce che si offre al lettore senza chiedere assoluzione né condanna.
Il protagonista, Ernesto Battistini, ex militante delle Brigate Rosse, costruisce il suo racconto come un tentativo di riappropriazione di sé. Non è una confessione in senso giuridico, né un atto di pentimento programmato. È piuttosto una discesa — lucida e ambigua — dentro la propria storia, dentro le pieghe di un’identità spezzata, dove la linea tra individuo e ideologia si fa sempre più sottile.
Carrozza non propone una ricostruzione storica in senso stretto. Il romanzo non pretende di spiegare il fenomeno BR, né di offrirne un’analisi politica esaustiva. La sua forza sta altrove: nel mettere il lettore a contatto diretto con una coscienza narrante disturbante e complessa, un personaggio che vive sospeso tra la quotidianità dell’operaio e l’estremismo del combattente clandestino, tra affetti familiari e violenza organizzata.
Il testo procede per frammenti di memoria, ricordi selettivi, giustificazioni implicite e improvvisi squarci di lucidità. Ernesto si racconta senza filtri, svela le sue contraddizioni, il fascino perverso dell’appartenenza politica, la sensazione di potere, ma anche il vuoto, la paura, la perdita di contatto con la realtà. L’ideologia, più che essere celebrata o demonizzata, viene mostrata come una forza assorbente, capace di riscrivere la percezione del mondo e di trasformare il senso morale.
In questo senso, Diario di un brigatista si avvicina a una forma di diario narrativo spinto, quasi “gonzo” nella sua esposizione dell’io, pur mantenendo una struttura consapevole e controllata. Non c’è compiacimento, non c’è pornografia della violenza. C’è un lavoro sottile sulla voce, sul ritmo interiore, sulla tensione tra ciò che è stato e ciò che resta.
Il romanzo riesce a trattare un tema delicatissimo con equilibrio, evitando il moralismo esplicito ma senza mai neutralizzare la gravità di ciò che racconta. Il lettore non viene istruito su cosa pensare: viene messo davanti a una coscienza che si svela, e costretto a confrontarsi con le proprie categorie di giudizio.
È questo forse l’aspetto più interessante del libro: la capacità di far convivere distanza critica e immersione emotiva, memoria storica e introspezione narrativa. Diario di un brigatista non cerca la provocazione fine a sé stessa, ma utilizza la letteratura come strumento per scandagliare le zone d’ombra della nostra storia recente.
Un romanzo scomodo, certo. Ma proprio per questo necessario, perché raccontare significa anche interrogare e perché solo attraversando la complessità si evita di trasformare il passato in una caricatura.